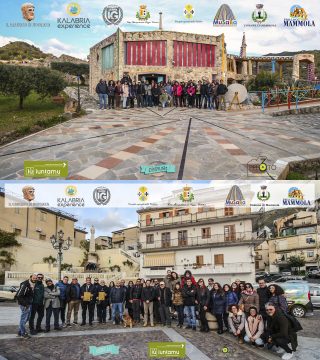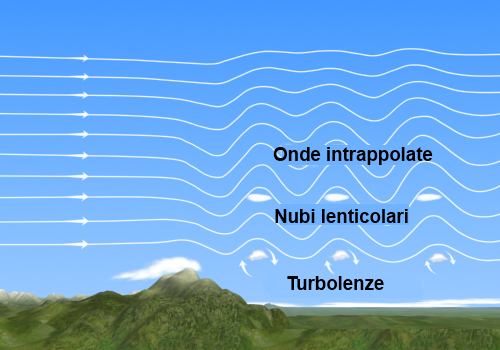Il Narciso era già noto agli antichi Egizi, ai Greci e ai Latini. Il nome Narciso, dal latino “narcissus” e dal dal Greco NARKAO “ναρκόω”, che significa: “stordire, intorpidire, fare addormentare,” da cui deriva anche la parola italiana “narcotico”, in riferimento al fatto che il suo forte profumo è capace di stordire. Nell’ antica Grecia il Narciso era noto perchè si credeva che avesse proprietà tranquillanti, anestetiche e antidolorifiche quindi era capace di stordire. Da qui la derivazione della parola “narcotico“. Gli egizi decoravano i propri defunti. Infatti, fiori di Narciso sono stati ritrovati nelle loro tombe in ottimo stato di conservazione dopo oltre 3000 anni.

Normalmente il Narcissus Tazetta alle nostre latitudini fiorisce da Dicembre fino a Febbraio, alcune volte anche anticipando le sue fioriture a Novembre. Non è ancora una pianta del tutto scomparsa, ma secondo il Prof. Domenico Minuto “è un fiore che andrebbe tutelato per la sua straordinarietà” .
Con questo articolo spiegheremo le caratteristiche, la storia, gli impieghi e le proprietà ed organolettiche del fiore di Narcissus allo scopo di porre l’attenzione dei nostri lettori atta a favorire politiche di conservazione e tutela di una pianta così bella quanto affascinante.
Il Narciso è uno dei fiori più celebrati nella mitologia greca e romana. Per gli antichi Greci, Narciso era un giovinetto figlio del fiume Cefiso e della ninfa Liriope. All’ età di quindici anni, bellissimo e ambiguo, era desiderato da giovani e fanciulle, che però lui respingeva perché non ritenuti all’ altezza. Ma l’ora del castigo venne quando uno dei suoi tanti innamorati implorò gli Dei sperando che si innamorasse anche lui ma che non possedesse chi lo amava. Un giorno, inseguendo un cervo, si specchiò nell’acqua e non riconoscendosi, si invaghì di se stesso; in seguito scoprì la verità struggendosi nell’ impossibile amore tanto da desiderare di uscire dal proprio corpo. Finchè, non decidendosi a darsi ad alcun spasimante, in quanto quello che desiderava era in lui, morì di consunzione. Quando le ninfe iniziarono a preparare il feretro e il rogo si accorsero che il corpo del giovinetto era sparito e in sua vece nel posto era sbocciato un fiore con i petali bianchi e giallo al centro.
Ovidio, nel libro III° delle Metamorfosi, racconta il mito di Narciso:
Narciso nacque da Liriope, la ninfa di fonte che, per la sua bellezza, fu rapita dal dio fluviale Cefiso e che, cingendola con le tortuose correnti dei suoi corsi d’acqua, la violò. La ninfa diede alla luce un bambino d’eccezionale fascino che chiamò Narciso. Preoccupata per il suo futuro, la neo-mamma consultò il veggente cieco Tiresia per sapere se il fanciullo avesse raggiunto la tarda vecchiaia. Tiresia così rispose: “Se non mirerà mai se stesso”. Al sedicesimo anno d’età Narciso era un giovane di tale avvenenza che molti ragazzi s’innamorarono di lui. Egli, indifferente, preferiva passare le giornate cacciando in solitudine. Tra gli spasimanti, la più incalzante era la ninfa Eco. Lei era stata punita da Giunone perché, tutte le volte che avrebbe potuto sorprendere sui monti le ninfe concubine di Giove, astutamente, la distraeva intrattenendola con lunghi discorsi aiutando le ninfe a sfuggire alle ire della dea gelosa. Quando Giunone si accorse dell’inganno disse: “Di questa lingua che mi ha ingannato potrai disporre solo in parte. Ridottissimo sarà l’uso che tu potrai farne”.

Eco, perciò, non poteva fare uso della propria voce se non per ripetere l’eco delle ultime parole che udiva. Quando incontrò Narciso e se ne innamorò, era già priva della parola. Eco lo scorse mentre Narciso cacciava i cervi in una foresta. La ninfa, che non sa tacere se si parla, ma nemmeno sa parlare per prima, cominciò a seguire le sue orme. Narciso, insospettito, si mise ad urlare: “C’è qualcuno”? Eco ripeté: “Qualcuno”. Stupito, egli scrutò tutti i luoghi, gridò a gran voce: “Vieni!”. Non mostrandosi nessuno, continuò: “Perché mi sfuggi”! Quante parole diceva, altrettante ne riceveva per risposta. Insistette e, ingannato dal rimbalzare della voce,“Qui riuniamoci” esclamò, ed Eco, che a nessun invito mai avrebbe risposto più volentieri, ripeté “Uniamoci”. Allegramente, balzando fuori del cespuglio, tentò di abbracciarlo. Narciso la respinse allontanandosi precipitosamente e lasciando ECO che, lamentandosi, continuava ancora a ripetere le ultime parole dette da lui. Afflitta e amareggiata, la bella ninfa vagò e, consumandosi per struggimento d’amore e di rimpianto, svigorì nel corpo. Non restarono che la voce e le ossa. La voce esiste ancora ed ovunque si può sentirla: è il suono che vive in lei e che ancora fa ECO nelle valli solitarie ripetendo le ultime sillabe delle parole pronunciate dagli umani. Le ossa, tramutate in sassi, sono state deposte vicino ad uno specchio d’acqua. La dea Nemesi, istigata da uno degli amanti respinti, alzando al cielo le mani, profetizzò: “Che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama”!
Nel bosco c’era Liriope, la fonte dalle acque limpide, argentee e trasparenti che mai pastori, caprette o altre bestie avevano toccato, che nessun uccello, fiera o ramo staccatosi da un albero avevano intorbidato. Attorno c’era un prato e un bosco che mai avrebbe permesso al sole di scaldare il luogo. Il giovane Narciso, spossato dalle fatiche della caccia, affascinato dalla bellezza del posto, qui venne a sdraiarsi per bere l’acqua della sorgente, ma, mentre cercava di calmare la sete, attratto dall’ immagine che vide riflessa, restò incantato e s’innamorò di una chimera: di un corpo che, però, era solo un’ombra. Dapprima non riconobbe se stesso, poi capì: “Io sono te“. Egli si lamentava poiché non riusciva a stringere e a toccare l’immagine. Ai suoi lamenti rispondeva solo la ninfa Eco che, nascosta nel bosco, li ripeteva. Neanche il bisogno di cibo e di riposo riuscì a staccarlo di lì. Disteso sull’erba, fissava con lo sguardo inappagato quella forma che l’ingannava. Poi, sollevandosi un poco, tese le braccia al bosco dicendo: “[…] Esiste mai amante, o selve, che abbia più crudelmente sofferto? Mi piace, lo vedo; ma ciò che vedo e che mi piace non riesco a raggiungerlo: tanto mi confonde amore. Un velo d’acqua ci divide! E lui, sì, vorrebbe donarsi: ogni volta che accosto i miei baci allo specchio d’acqua, verso di me si protende offrendomi la bocca. Diresti che si può toccare; un nulla, sì, si oppone al nostro amore. Chiunque tu sia, qui vieni! Perché m’illudi, fanciullo senza uguali? Io, sono io! Ho capito, l’immagine mia non m’inganna più! Per me stesso brucio d’amore, accendo e subisco la fiamma!” Resosi conto dell’impossibilità di amare e di baciare l’immagine di sé riflessa nella superficie d’acqua, Narciso si lasciò morire. “[…] Ormai il dolore mi toglie le forze, e non mi resta da vivere più di tanto: mi spengo nel fiore degli anni […]”. Si avverava la profezia di Tiresia. Allorché le Naiadi e le Driadi vollero prendere il suo corpo per dargli degna sepoltura, scoprirono un bellissimo fiore dai petali dal colore dello zafferano col capo chinato sull’acqua alla ricerca del proprio riflesso. A quel fiore fu attribuito il nome Narciso. Lo scrittore greco Pausania ha raccontato che il Narciso esisteva già prima del personaggio di Ovidio visto che il poeta epico Pamphos, vissuto molto anni prima, nei suoi versi ha narrato che Persefone, quando fu rapita da Ade, stava raccogliendo dei fiori di Narciso.
Da questa narrazione si evince che nel linguaggio dei fiori il Narciso è il simbolo “degli egoisti e delle persone piene di sé”. Indica, pertanto, “vanità, egoismo, incapacità di amare”. Diversa è la simbologia orientale. In Cina il Narciso è simbolo di “prosperità e di felicità” ed è donato in segno augurale di buon anno.
Nella Bibbia ad esempio il Narciso e il Giglio, per i loro colori chiari e luminosi, sono simbolo solare di “rinascita” e raffigurano la primavera. Salomone, nel Cantico dei Cantici ( 2,1), nel Colloquio fra gli sposi scrive: “Io sono un narciso di Saron, un giglio delle valli. Come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle”. Nel nuovo Israele Isaia (35-1,2) scrive: “Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio”.
Secondo la tradizione, Narciso, era un santo di Gerusalemme che visse oltre cento anni e ricordato per aver compiuto il miracolo della conversione dell’acqua in olio necessario per alimentare le lampade della sua chiesa. Il suo onomastico ricorre il 29 di ottobre.

Il genere Narcissus comprende 40 specie di piante bulbose appartenenti alla famiglia delle Amaryllidaceae e originarie dell’Europa, dell’Africa settentrionale, del Giappone e della Cina dove fu introdotto nell’ottavo secolo attraverso la via della seta. Italia, Spagna e Portogallo sono i Paesi dove è più facile trovare Narcisi allo stato spontaneo presenti in una vasta gamma di habitat. Le specie selvatiche spesso abbondano nei prati e nei boschi umidi di pianura e di montagna fino a 2000 metri La coltivazione del Narciso è iniziata intorno al XVI secolo in Inghilterra e in Olanda. Ancora oggi le due nazioni, insieme agli Stati Uniti, sono le maggiori produttrici di Narcisi. I Narcisi si ibridano tra loro con gran facilità e le numerosissime varietà di ibridi di tanti colori hanno originato uno dei generi di bulbose più coltivate. In passato, e questo fino agli anni ’80 vi era una piccola filiera di commercio per l’industria profumiera che nel sud Italia (in particolar modo nel Reggino) ha rappresentato una piccola fonte di reddito in seguito decaduta sul mercato della richiesta a causa dell’invenzione di materie chimiche che sostituirono la raccolta a mano delle donne che si recavano nelle campagne ogni mattina per raccogliere i piccoli fiorellini che dalle nostre parti spesso venivano soprannominati con il termine di “Pasta e Ciciri” – tradotto = (Pasta e ceci).
Sono belle storie, che ci raccontano secoli di storia legate alle credenze, alla mitologia che in noi suscitano molte suggestioni. La Calabria profumata di cui andar fieri era il giardino perfetto per i nostri antenati greci che la resero una vera e propria serra naturale, ideale per la produzione di materie prime ed olii essenziali così come oggi noi conosciamo per il Bergamotto divenuto in poco tempo un’industria fiorente della fascia Jonica reggina compresa tra Reggio Calabria e Gioiosa Jonica, ma di questo prezioso frutto ve ne parleremo al prossimo articolo.

 In questo luogo è possibile notare anche dei pezzetti di zolfo, dovuti ad un processo di fossilizzazione di una probabile foresta esistita secoli fa. Il prof. Sebastiano Stranges fa notare anche alcune rare specie di piante autoctone, in via di estinzione, fra queste spicca il Ginepro. Il ginepro fenicio è stato ampiamente utilizzato, fin dall’ antichità, con alberelli scortecciati si preparavano attaccapanni e supporti per la macellazione, impalcature per pozzi, travature varie. Il legno veniva anche ampiamente utilizzato per la costruzione di telai, piattaforme lignee per barche, altari, sedie, cassapanche, lavori di intarsio, utensili per la casa. Il legno si presta bene anche come legna da ardere, bruciando con fiamma vivace, ma, per il suo pregio in altri settori, era scarsamente utilizzato a questo scopo. In questa zona, sono stati anche ritrovati importanti reperti archeologici (come frammenti di anfore provenienti da Corinto), caratterizzati da striature in blu, e un forno particolare che serviva per l’essiccazione di uva, fichi e pere (molto coltivate fino ai primi del ‘900).
In questo luogo è possibile notare anche dei pezzetti di zolfo, dovuti ad un processo di fossilizzazione di una probabile foresta esistita secoli fa. Il prof. Sebastiano Stranges fa notare anche alcune rare specie di piante autoctone, in via di estinzione, fra queste spicca il Ginepro. Il ginepro fenicio è stato ampiamente utilizzato, fin dall’ antichità, con alberelli scortecciati si preparavano attaccapanni e supporti per la macellazione, impalcature per pozzi, travature varie. Il legno veniva anche ampiamente utilizzato per la costruzione di telai, piattaforme lignee per barche, altari, sedie, cassapanche, lavori di intarsio, utensili per la casa. Il legno si presta bene anche come legna da ardere, bruciando con fiamma vivace, ma, per il suo pregio in altri settori, era scarsamente utilizzato a questo scopo. In questa zona, sono stati anche ritrovati importanti reperti archeologici (come frammenti di anfore provenienti da Corinto), caratterizzati da striature in blu, e un forno particolare che serviva per l’essiccazione di uva, fichi e pere (molto coltivate fino ai primi del ‘900).