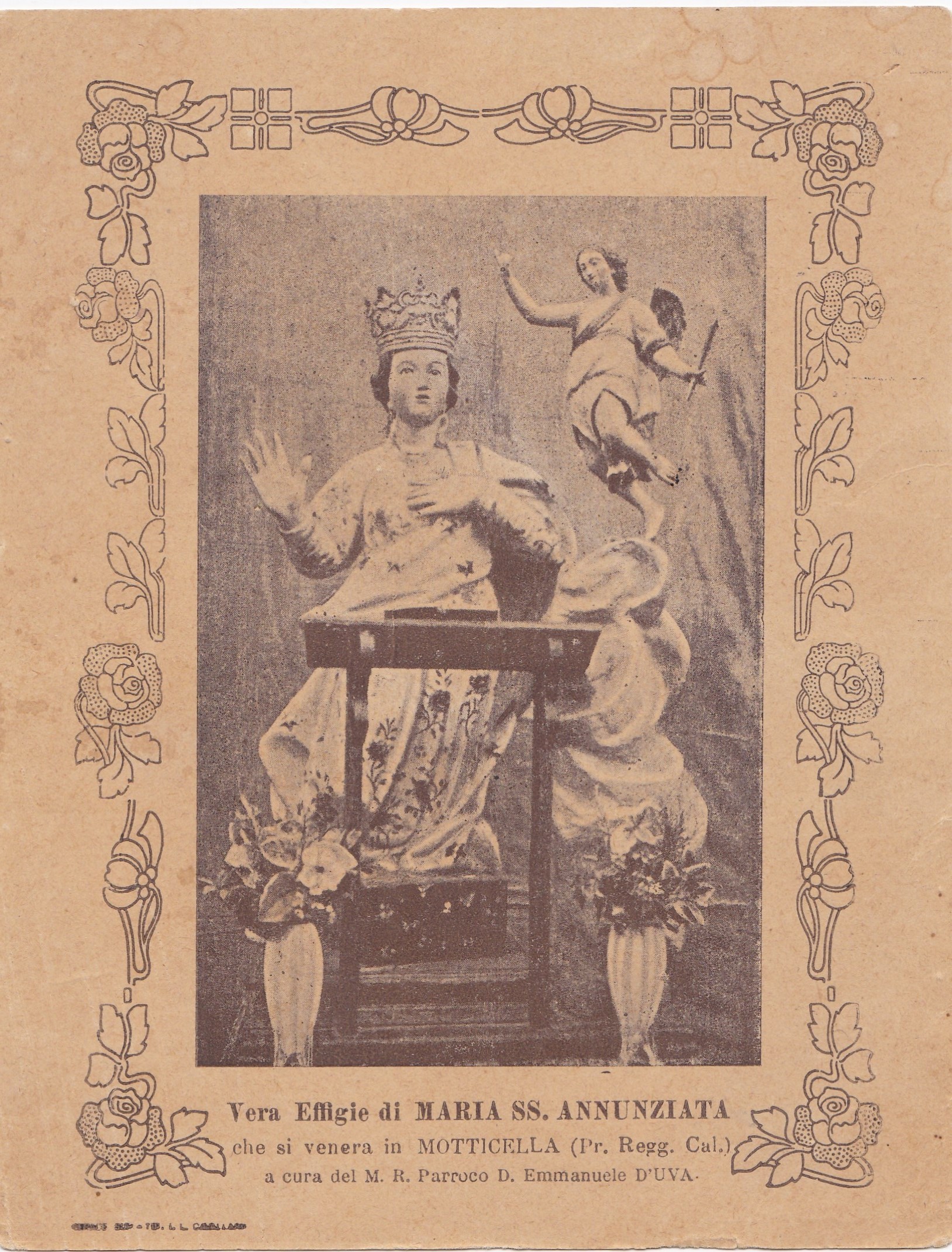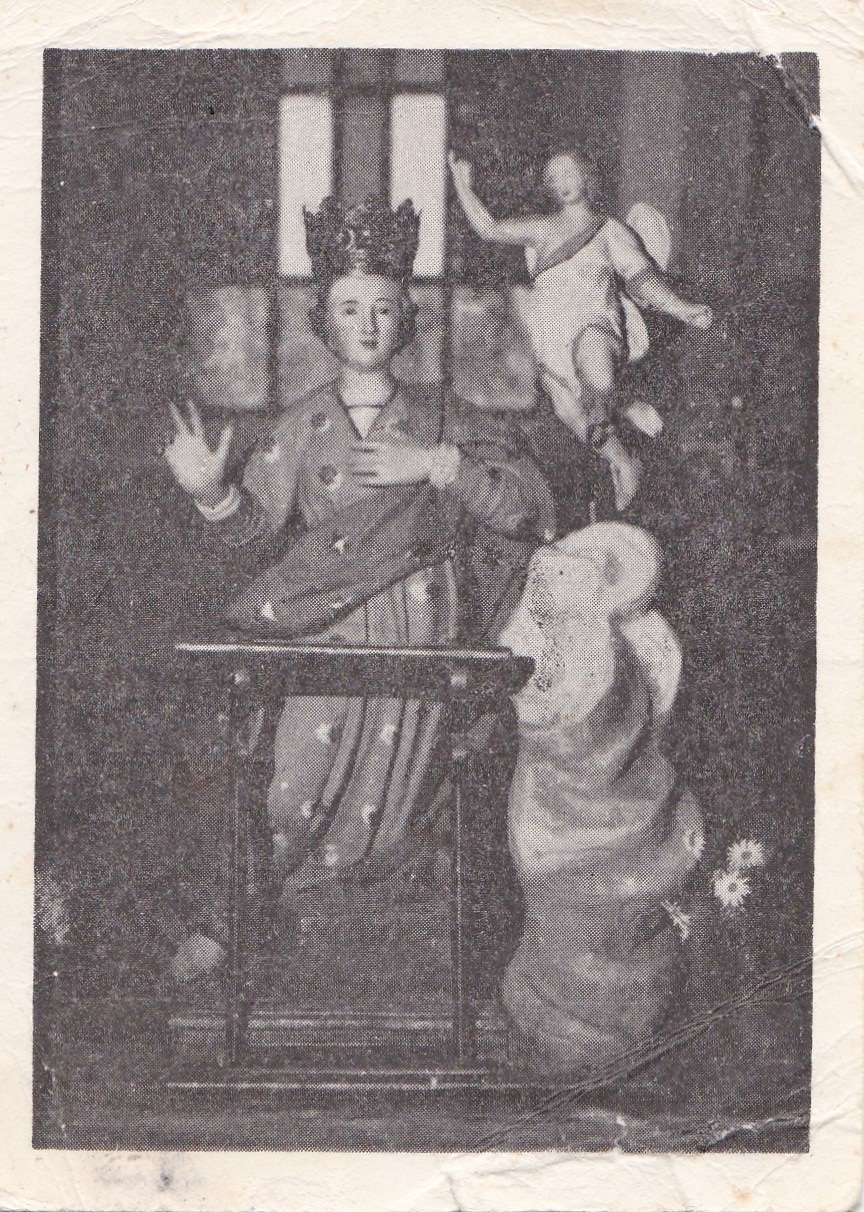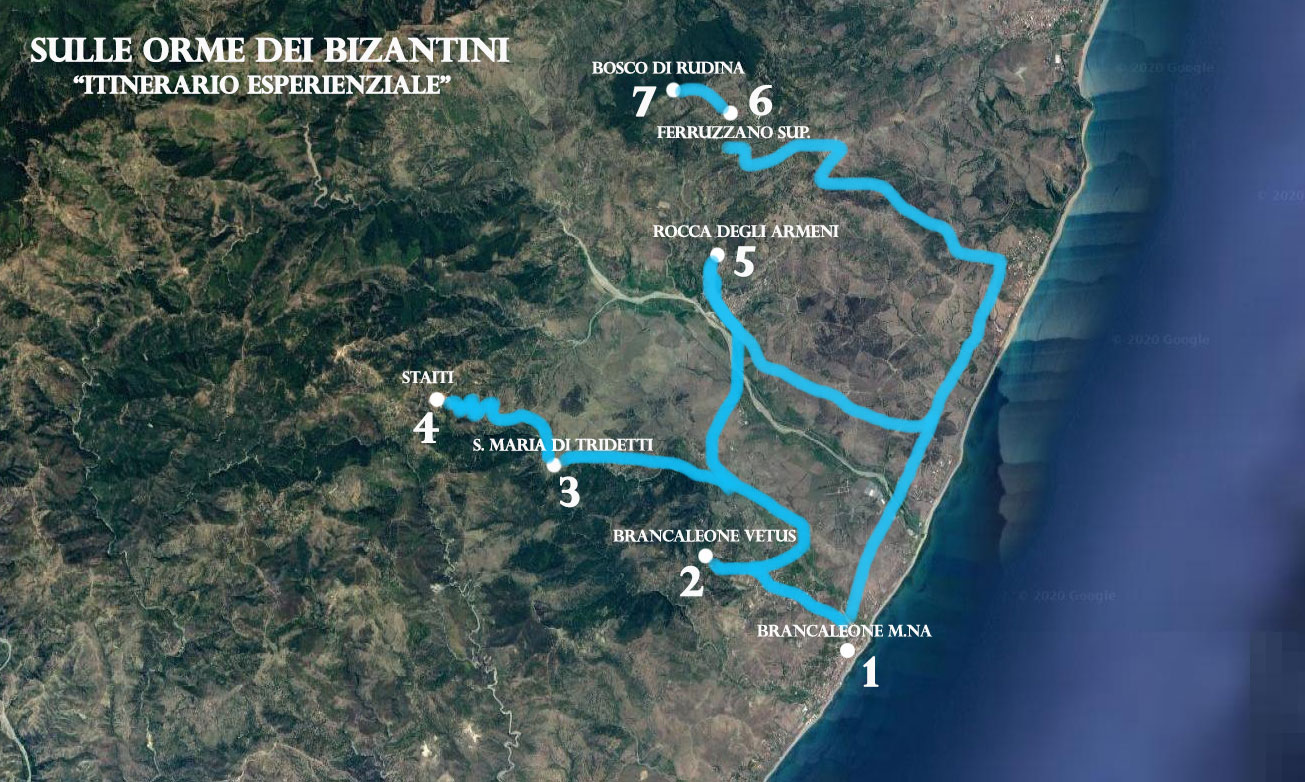Tra i borghi più interessanti e caratteristici dell’entroterra Calabrese in provincia di Reggio Calabria vi è sicuramente San Giorgio Morgeto, lo abbiamo percorso tante volte, e siamo rimasti colpiti dalla sua straordinaria bellezza. Soprattutto per il ricco patrimonio Storico, Archeologico e Gastronomico. Un borgo da vivere, da riscoprire attraverso le sue vie antiche, i suoi palazzi, i suoi monumenti, la sua gente..
Le origini di San Giorgio Morgeto;
Plinio, Strabone e Proclo, narrano del popolo italico dei Morgeti; essi, secondo alcune ricostruzioni, avrebbero costruito una fortificazione attorno alla quale sarebbe sorto il primo insediamento. La leggenda colloca tale evento nell’anno 2349 a.C. e lo descrive quale opera del Re Morgete, figlio del Re Italo, della stirpe degli Enotri. Si narra, che il primo abitante della Calabria sarebbe stato Aschenez, nipote di Jafet, figlio di Noè. Circa 850 anni prima della guerra di Troia, Enotrio e Paucezio avrebbero sconfitto gli Aschenazi scacciandoli dalla Calabria. Enotrio avrebbe regnato 71 anni lasciando come erede il figlio Enotrio-Italo, il cui regno sarebbe durato 50 anni e che avrebbe avuto come successore Morgete, il quale, per la consuetudine dei suoi predecessori, avrebbe cambiato il nome dell’Italia in quello di Morgezia. Fu in suo onore che venne fondata Morgeto dove egli veniva adorato come un Dio. Nel IX secolo, la diaspora dei monaci bizantini, interessò anche il territorio di Morgetum e ne influenzò l’attività economica, culturale e religiosa. Essi edificarono un monastero dedicato a San Giorgio di Cappadocia ed una chiesa consacrata a Santa Maria dell’Odigitria o di Toxadura, che divennero un punto di riferimento per l’intero territorio e per le genti che vi abitavano. Come riporta San Nilo, quando vi furono le incursioni dei Saraceni che distrussero i centri della Vallis Salinarum e vi portarono la peste, Morgetum e il suo monastero non subirono alcun danno, anzi accolsero una parte dei profughi di Taureana. I monaci, la cui presenza era volta a convertire al cristianesimo gli abitanti (che veneravano il Re Morgete quale dio), attribuirono l’incolumità alla protezione di San Giorgio e nel 1075 il nome Morgetum venne modificato in San Giorgio.
Oggi San Giorgio è un paesino collinare di poco più di 3.000 abitanti, inserito in un contesto naturalistico e culturale che vanta una moltitudine di siti di interesse facilmente raggiungibili grazie all’ ubicazione geografica ben collegata sia dal versante ionico e sia dal versante tirrenico.
 Il sito archeologico di Altano;
Il sito archeologico di Altano;
Non lontano dall’attuale San Giorgio Morgeto, sul piano di Casciano o Casignano, in località Sant’ Eusebio, emergono ancora i resti di una cinta muraria e torri circolari che inducono a pensare alle origini della città di Altanum o Casignano. Controverse sono le ipotesi sulle origini di questo insediamento. Storici e antropologi hanno però studiato i reperti rinvenuti dai molteplici scavi, ipotizzando differenti versioni. Dagli studi classici risulta che, nel periodo del dominio locrese, il castello di Morgetum era in rapporto con altre due postazioni militari: Templum Musarum (l’odierna Cinquefrondi) ed Altanum che, quale avamposto locrese, subì in varie epoche diverse incursioni. La devastazione ed il saccheggio della città fu per opera di Totila, il quale, dopo averla rasa al suolo le volle cambiare significativamente il nome in “Casegghianum”, da cui appunto derivò il toponimo “Casignano”. Nel XV secolo Casignano rientrava tra i casali della baronia di San Giorgio. Nell’800 Altanum era già oggetto dell’interesse degli archeologi, ma nel 1921 il grande archeologo Paolo Orsi incaricò De Cristo di dirigere gli scavi che portarono alla luce i resti di due cisterne, monete in bronzo, materiale ceramico e frammenti di ossa. Tra le diverse letture del sito, quella del Prof. Domenico Minuto, ipotizza che Altanum fosse una fortificazione bizantina, dell’età Giustinianea, molto probabilmente utilizzata come avamposto militare durante il conflitto con i Goti e Longobardi.Testi antichi fanno risalire Altanum o Casignano come luogo che diede i natali a Sant’Eusebio Papa.
“Era la Città Altano nelle pendici dell’Apennino, in un colle molto ameno, verso l’Ostro, nel sinistro lato di S. Giorgio, distante però da lui per ispatio di tre miglia in circa, dove insino ad hoggi si veggono le reliquie dell’antiche mura…” (Girolamo Marafioti, 1601)
Il Convento dei Padri Domenicani;
Tra i più grandi conventi della Calabria, le sue fabbriche sono veramente grandiose e degne di una grande città. A volerlo è stato Battista Caracciolo conte di Gerace e signore di San Giorgio. Venne completato nel 1473 annesso alla chiesa di santa Maria Annunziata edificata dal fratello Giovanni Caracciolo nel 1393. Purtroppo parte dell’edificio crollò nel terremoto del 1783. Fu un centro di grande cultura e scuola per i novizi. Tra le sue mura vissero Fra Tommaso Campanella, il santo vescovo Piromalli e il Vescovo di Gerace Domenico Diez de Aux.
La chiesa dell’Annunziata;
E’ una delle più imponenti, eleganti chiese conventuali della Calabria. La prima fabbrica risale al 1393 ad opera dei Baroni Caracciolo di San Giorgio. Nel 1499 la chiesa venne restaurata, ma crollò a causa del terremoto del 1783. Venne poi ricostruita nel 1815 e ampliata così come si presenta oggi: con un portale imponente in granito, con al centro lo stemma della famiglia Milano. L’edificio al suo interno si presenta ad unica navata con otto cappelle laterali (quattro per lato) racchiuse da arcate dedicate ai santi domenicani. Tra le statue in legno spicca il gruppo dell’Annunciazione ad opera di Vincenzo Scrivo, posto sopra l’Altare maggiore del XVIII secolo; due statue lignee dei San Cosma e Damiano(forse della bottega dei Morani), la statua di San Domenico, San Ciro e la settecentesca effigie della Madonna del Rosario portata in processione il venerdì Santo nella tradizionale “affruntata” di Pasqua.
La chiesa di Sant’Antonio di Padova;
Fu fondata nel 1693 annessa al monastero Basiliano, venne distrutta dal terribile terremoto del 1783, fu poi ricostruita dal Cav. Giovan Francesco Ammendolea, alla cui nobile famiglia è stato devoluto lo Jus Patronato. Sull’altare è posta la scultura lignea di Sant’Antonio di Padova (opera settecentesca) realizzata dallo scultore campano Gennaro D’Amore, voluta dal Marchese Giovanni Domenico Milano. La statua fu poi restaurata malamente nel 1983. Durante un recente restauro, nella piccola chiesetta sono riemerse le cripte gentilizie che si pensa fossero ad uso dalla famiglia Celano o forse dagli stessi monaci del monastero.
La chiesa del Carmine;
Dedicata alla Madonna del Carmelo è annessa al Palazzo Ambesi. Sorge sul sito dell’antico Monastero dei Padri Carmelitani. Esternamente la chiesa presenta un frontone spezzato. Il portale d’ingresso è sormontato da un ampio finestrone, al suo interno si apre un’ampia navata con al centro l’altare su cui tabernacolo è collocala una pregiata tela seicentesca.
 L’arco di San Giacomo;
L’arco di San Giacomo;
Nel lato sud-est del Palazzo Milano possiamo ammirare l’elegante Arco Palatino in granito che ci immette alla Chiesa dedicata a San Giacomo fatta costruire nell’ultimo decennio del ‘500 dal Marchese Giacomo Milano
Il Passetto del Re “il vicolo più stretto d’Italia”;
Si tratta di un particolare vicolo largo appena 40 cm; e vanta un bellissimo primato che lo colloca sul podio del “vicolo più stretto d’Italia” si trova nelle vicinanze del castello ed è legato a una leggenda popolare. Durante le invasioni questo stretto passaggio costituiva una via di fuga per il Re Morgete, per poi far disperdere le sue tracce nei dedalo di vicoli dell’abitato di San Giorgio. Una via di fuga per la salvezza!? Forse per questo motivo, secondo la tradizione, percorrere il “Passetto del Re” è un atto che porta fortuna.
La Fontana Maggiore;
Nella Piazza principale di San Giorgio Morgeto spicca la monumentale Fontana Maggiore, Fontana Grande o detta anche “Fontana Bellissima” posta dinanzi al prospetto principale di Palazzo Milano, costituiva all’epoca un preziosissimo ornamento proprio all’interno dei giardini del Palazzo (oggi Piazza dei Morgeti) Potremmo definirla la più bella fontana pubblica della Calabria, fatta costruire dal Marchese Giovanni Milano II nel 1664. E’ realizzata in granito locale, si compone di quattro gradini alla base di forma ottagonale e si sviluppa su tre vasche sovrapposte degradanti, al cui vertice si erge una statua marmorea della Venere. La vasca alla base originariamente possedeva quattro cigni scolpiti in granito (andati purtroppo perduti) da essa sgorga un’acqua sorgiva dalle caratteristiche chimico organolettiche importanti, così come tutte le fontane del borgo di San Giorgio Morgeto a cui si attribuiscono ottimi effetti benefici .
I Baghari
San Giorgio Morgeto è anche ricca di vicoli e vicoletti davvero caratteristici, come non perdersi tra queste viuzze strette, ma che spesso varcano i Palazzi nobiliari attraverso imponenti e maestosi archi. Vengono chiamati in dialetto locale “Baghari”. Sul Corso Giacomo Oliva, proprio nei pressi della Piazzetta dedicata a Francesco Florimo con il busto bronzeo, vi è l’accesso a Via Pasqua caratterizzata da un Bagharo che presenta una originale curiosità. Inserite tra le pareti di destra e a sinistra piccole nicchie con scolatoio, lasciano presupporre si trattino di latrine pubbliche, sicuramente di dubbia costruzione e collocazione storica, ma di sicuro è una delle particolarità che rende San Giorgio Morgeto ancora più ricco di storia, vita e vicissitudini che dall’alto medioevo hanno lasciato a questo borgo quel fascino intrigante ma al tempo stesso misterioso.
Le Dimore Storiche e Palazzi nobiliari;
San Giorgio Morgeto è ricca di prestigiosi e antichi Palazzi storici come non rimanere incantati di fronte alla maestosità di Palazzo Ammendolea-Florimo, all’interno del quale ebbe i suoi natali il famoso musicista Francesco Florimo, e poi ancora il Palazzo Fazzari proprio accanto alla chiesa dell’Annunziata di fabrica settecentesca, famoso per il suo prestigioso e ben conservato chiostro, da cui si accede attraverso un maestoso portale bugnato realizzato in pietra locale, che ormai è diventata la location preferita per gli sposi. Poi ancora; Palazzo Oliva e Palazzo Ambesi, situati lungo le vie del centro storico; Palazzo Milano, sede della famiglia feudataria che detenne il territorio di San Giorgio dal 1568 fino al sovvertimento del periodo feudale.
La Scala Beffarda e la leggenda di Fata Morgana;
Non molto distante dalla chiesa dell’Assunta, si giunge in una delle particolarità urbanistiche medievali di San Giorgio Morgeto; Conosciuta con il nome Scala Beffarda essa è un particolare esempio di scalinata sfalsata e davvero singolare. Per la sua caratteristica unica nel suo genere, numerose leggende aleggiano attorno a questa scalinata che spesso sembra di percepire attraverso gli spifferi d’aria che tra gli stretti vicoli narrano storie e leggende incredibili.
Una delle leggende legate alla Scala narra che fata Morgana, sorellastra malvagia di Re Artù (il cui spirito aleggia da secoli tra Calabria e Sicilia e nei dintorni dello Stretto di Messina) avesse sottratto ad Artù il fodero di Excalibur “la Spada nella Roccia”, che aveva il potere di proteggerlo in battaglia. Nascose questo ai piedi dell’imponente maniero, certa che Artù sarebbe venuto a cercarlo per salvare la sua vita e continuare a lottare per l’affermazione di giustizia e verità. E così accadde, il cavaliere ivi sopraggiunto interrogò Morgana, che maestra in inganni e illusioni rispose “cercalo nel paese dei mille vicoli, laddove una gradinata si farà beffa di te”, Artù, per preservare l’onore (che valeva più che salvar la vita), rinunziò e fece ritorno a Salsbury privo del suo fodero, consapevole del suo fatale destino, ove poi perì lottando contro Mordred (figlio della stessa Morgana). Si narra che talvolta nel vento ancora riecheggi la beffarda risata, che solo gli animi eletti dei viandanti dal cuor puro e leale riescono a udire e dalla quale sanno di dover rifuggire.
La chiesa parrocchiale dell’Assunta
La chiesa dell’Assunta di fondazione seicentesca è posta al centro del paese, fu ricostruita e rimaneggiata più volte. La struttura attuale della chiesa, risale al 1933 quando è stata nuovamente rifatta in stile romanico, con il campanile ed orologio annesso. Ha origini antichissime, probabilmente essa apparteneva all’ Arcivescovato di Altano. Secondo fonti storiche questa chiesa venne eretta sin dai tempi degli Apostoli, quando San Pietro e San Paolo vennero nelle Calabrie e per mezzo di vescovi da loro ordinati, diffusero la fede cristiana fra i popoli. Fu proprio Santo Stefano da Nicea, (primo Arcivescovo di Reggio) a convertire le popolazioni della provincia, tra cui anche i Morgeti. Ci si accede alla chiesa attraverso un sistema di scale laterali, entrando dalla porta d’ingresso (posta ad occidente), si entra nell’unica navata che apre la visuale all’imponente altare maggiore (posto ad oriente). Il tempio custodisce delle pregiatissime statue lignee dei compatroni San Giorgio e San Giacomo, un organo a canne di scuola napoletana e un altare maggiore in marmi policromi settecenteschi.
 Di recente la Chiesa è stata interamente restaurata. I lavori iniziati nel 2011 sono stati terminati nel 2013. Sul retro parete esterna della chiesa in corrispondenza dell’abside è ancora possibile osservare la “Pietra Santa”. Ritornata alla luce nel corso degli ultimi restauri si pensa che probabilmente era un elemento che comprendeva l’antico altare della chiesa, su di essa è ancora visibile l’incisione di una croce. Probabilmente consumata dal bacio dei fedeli.
Di recente la Chiesa è stata interamente restaurata. I lavori iniziati nel 2011 sono stati terminati nel 2013. Sul retro parete esterna della chiesa in corrispondenza dell’abside è ancora possibile osservare la “Pietra Santa”. Ritornata alla luce nel corso degli ultimi restauri si pensa che probabilmente era un elemento che comprendeva l’antico altare della chiesa, su di essa è ancora visibile l’incisione di una croce. Probabilmente consumata dal bacio dei fedeli.
San Giorgio, il Santo Patrono:
San Giorgio nacque in Cappadocia da genitori cristiani e visse nel III secolo, sotto l’impero di Diocleziano. Arruolato nella milizia imperiale salì al grado di Capitano. Combattè sotto una nobile bandiera, quella divina. Nella terribile persecuzione di Diocleziano animava i Cristiani perseguitati dai musulmani a ricevere con forza il martirio, a non cedere alle lusinghe dei tiranni, a professare sinceramente Gesù Cristo. Infatti nell’ iconografia tradizionale viene raffigurato con la lancia che uccide il drago, simbolo del male!
Il Castello Normanno di Re Morgete;
Il Castello sorge proprio sulla cima del colle di San Giorgio Morgeto è domina tutto il paese e le valli sottostanti. Per accedere al castello si percorre la scalinata del Monumento “Faro ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale” (Opera dello scultore Fortunato Longo) da qui un piccolo sentiero ben delimitato da staccionate, porta immediatamente all’interno dell’area ove ricadono i ruderi delle mura di cinta e del Mastio che consente (ai più esperti) l’accesso al suo interno. Un scalinata esterna porta al piano superiore dove è possibile ammirare uno dei panorami più belli della la piana del Tauro; qui la vista spazia dal Monte Sant’Elia fino a Capo Vaticano, e nelle giornate terse è possibile ammirare in lontananza le isole Eolie con lo Stromboli in primo piano. Altri tangibili resti sono le mura di cinta ed i basamenti delle torri, oltre alla grande cisterna, mentre il campo sottostante è una grande terrazza ai piedi dell’antico maniero e sede ormai di grandi eventi culturali e rievocativi che ospita concerti e manifestazioni culturali.
Miti e leggende di San Giorgio Morgeto;
Tra queste mura silenziose, riecheggiano ancora straordinarie quanto inquietanti leggende, che abbiamo appreso proprio dai racconti degli anziani del luogo, così cordiali che talvolta invitano a gradire un bicchiere di vino o perfino a sedere a tavola con loro.
La chioccia dai pulcini d’oro;
Pare che si nascondessero dietro un grande masso accanto alla fortezza e si farebbero vedere soltanto agli occhi dei semplici, solitamente a mezzogiorno esatto o nel cuore della notte. Per afferrarli sarebbe necessario adempiere un rito complesso, ma il fortunato possessore da lì a poco morirebbe. Per tale motivo i pennuti si troverebbero ancora lì, in attesa che qualche temerario osi catturarli.
L’oracolo di re Morgete;
Durante il paganesimo si consultavano gli Dei per una previsione, uno di questi Dei assunse le sembianze di “Re Morgete” un Dio dispensatore di oracoli. Questi, al lume di fiaccole o della luna piena, tra le mura del Castello poteva manifestare le sue visioni notturne da interpretare.
Le jovisse;
Anche le “Jovisse” (leggiadre figlie di Giove), potevano vedersi aggirare tra i boschi intorno alla fortezza o per le stanze dell’antico maniero, mandando in confusione chiunque li avesse incontrate.
L’Artigianato di San Giorgio Morgeto;
Tra le tante cose da visitare a San Giorgio Morgeto, sicuramente sono le numerose botteghe artigiane: Il Mastro Cestaio Aldo Mammoliti, la bottega del vetraio Simone Surace, la bottega equo-solidale, la fabbrica dei profumi Carpentieri e le numerose Aziende agricole dell’Olio che da queste parti sono molto rinomate, come ad esempio l’Azienda Fazari, leader di un prodotto di qualità esportato in tutto il mondo, oltre alle numerose botteghe di Ebanisteria famose per la qualità dell’intaglio e delle tecniche.
 Personaggi Illustri: Francesco Florimo;
Personaggi Illustri: Francesco Florimo;
Francesco Florimo nacque a San Giorgio Morgeto il 12 ottobre 1800 da Michelangelo e Mariantonia Oliva. Sin da piccolo Francesco manifestò attitudini musicali tali da far meravigliare lo zio omonimo, ottimo conoscitore di musica tanto che quest’ultimo “notava sorpreso, come il nipote potesse ripetere con precisione e all’istante la varie suonate, ch’egli intonava sul cembalo”. Questi motivi indussero i genitori e lo stesso zio a far allontanare Francesco dal paese natìo all’età di diciassette anni per iscriverlo al Conservatorio di San Sebastiano in Napoli (divenuto poi “San Pietro a Majella”). Ebbe come maestri: Tritto (contrappunto), Elia (pianoforte), Fumo (armonia), Zingarelli (composizione) ed il Crescentini (canto), applaudito esecutore di opere del Cirnarosa. Suoi compagni furono, tra gli altri: Vincenzo Bellini, Saverio Mercandante, Carlo Conti, Luigi e Federico Ricci, Michele Costa, Enrico Putrella, Giovanni Pacini, Carlo Coccia, Pietro Coppola. Circondato da sì grandi maestri e da validi compagni, Francesco Florido proseguì con profonda sensibilità nell’approfondimento degli studi musicali sino a conseguire nel 1823 il diploma di direttore d’orchestra e il diploma di abilitazione all’insegnamento del canto e del pianoforte.
Nel 1835 fu nominato Primo Direttore Artistico della Società Filarmonica di Napoli. Divenne quindi membro di molte accademie, fra cui: la Pontaiuiana, la Reale d’Archeologia e L’Archeologica, quella di Lettere e Belle Arti, tutte in Napoli; la Musicale di 8. Cecilia in Roma, le Filarmoniche di Palermo, Catania, Messina e Bologna. Prodigo verso tutti coloro che come lui desiderava divulgare le opere musicali, Francesco Florimo si fece promotore di un’accademia di studi belliniani e di diversi concorsi musicali intitolati allo stesso Bellini. Francesco Florimo fu anche maestro di canto e di pianoforte fino al 1850 e nel 1879 fu nominato direttore dei concerti vocali. La morte lo colse il 18 dicembre del 1888, a seguito di una polmonite causatasi uscendo da una festa d’arte.
L’ingegno e l’operosità di Francesco Florido furono fregiati da molte onorificenze; meritò infatti la Commenda dei SS. Maurizio e Lazzaro, la croce dell’ordine di San Michele di Baviera, la medaglia del busto di Simone Bolivar e. un anno prima di morire, la nomina a Grande Ufficiale della Corona d’Italia.
EVENTI DA NON PERDERE:
Ad Agosto; Festa medioevale
a Natale; Presepe vivente per le vie del borgo
a Pasqua; Affruntata del venerdì santo
23 Aprile; Festa Patronale di San Giorgio
23 Aprile; Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, istituita e promossa dall’UNESCO