Che la Calabria fosse piena di miti, leggende e misteri è cosa ormai assodata! La fantasia dell’uomo ha sempre cercato di trovare delle spiegazioni logiche a strani fenomeni che insistono su luoghi, castelli, borghi e foreste dell’intero territorio, così come in ogni parte d’Italia non è difficile trovare storie di spiriti, fantasmi e strane creature.
Oggi ci focalizzeremo sui misteri che si tramandano per generazioni nella nostra regione e che sembrano in qualche modo, condurci in atmosfere e tempi lontani, in un passato che ancora esiste e vuole esistere nel nostro immaginario.
Sono gli anziani che ci consentono di fare un passo indietro nel tempo alla scoperta di storie e vicende che vuoi o non vuoi, rimangono ancora incarnate dentro quelle mura precarie che hanno attraversato secoli di vita e vicissitudini dai contorni indefiniti e dai significati simbolici profondi.
Tra le leggende che ancora oggi si tramandano di generazione in generazione nella nostra Regio emerge quel forte senso di appartenenza ad un passato le cui leggende erano parte integrante della vita quotidiana, che aveva una concezione sicuramente più simbolica che altro.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA: La Fata Morgana

Sulle rive dello Stretto, dal “chilometro più bello di Italia”, come definì il lungomare di Reggio Calabria D’Annunzio, si può osservare la Fata Morgana, un fenomeno ottico simile a un miraggio che si può vedere dalla costa calabra quando aria e mare sono immobili. La costa siciliana, vista da quella calabrese, sembra distare pochi metri. Si possono distinguere molto bene le case, le auto e addirittura le persone che camminano nelle strade di Messina. Il tutto avviene quando sulla superficie del mare, minuscole goccioline di acqua rarefatta, fanno da lente di ingrandimento. Si racconta che al tempo della conquista normanna di tutto il Sud, avendo gli Altavilla compiuto l’unificazione di tutta la parte meridionale della penisola, Ruggero di Altavilla, meditasse sulla conquista della Sicilia. Fu così che la Fata Morgana lo tentò, facendogli avvicinare la costa siciliana a pochi metri. Ruggero, però, non accettò l’aiuto della fata, non volendo prendere l’isola con l’inganno. E così, senza l’aiuto del sortilegio, impiegò ben 30 anni per completarne la conquista. Un’altra leggenda racconta di un capo barbaro, che, arrivato a Reggio, bramasse di prendere l’isola siciliana. Una bella donna gli si presentò e gli fece toccare con mano l’isola. Convinto di poter passare lo Stretto con una breve nuotata, il condottiero barbaro scese da cavallo e si tuffò in mare. subito la fata ruppe l’incantesimo e il capo barbaro affogò miseramente in mare. In realtà, consisterebbe in un fenomeno visivo che si verifica in particolari condizioni atmosferiche. Un’illusione ottica dovuta ad un’inversione di temperatura negli strati bassi dell’atmosfera, quelli che sono a contatto con il mare, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando il cielo è più terso, a causa della diversa densità dell’aria; dalla sponda è possibile vedere le immagini dell’altra costa riflesse e persino moltiplicate dal mare, trasformato in un immenso specchio.
Pentedattilo (RC) La stage degli Alberti

In provincia di Reggio Calabria, incastonato tra le montagne del versante jonico dell’Aspromonte, sorge Pentedattilo, il nome stesso del piccolo borgo prende il nome da una conformazione di roccia sulla quale si innalza simile ad una mano gigante (dal greco penta daktilos, ovvero cinque dita). Edward Lear, celebre artista e scrittore e viaggiatore inglese, nel suo “diario di un viaggio a piedi” parla della bellezza del luogo e delle sue meravigliose rocce, maestose e selvagge. Ecco come appariva al visitatore il piccolo borgo verso la metà dell’800. <<selvagge sommità di pietra spuntano nell’aria, aride e chiaramente definite in forma (come dice il nome) le case di Pentedattilo sono incuneate all’interno delle spaccature e dei crepacci di questa spaventosa piramide selvaggia, le abitazioni alla sua superficie consistono in poco più che un piccolo villaggio>>. Durante il periodo greco-romano il piccolo borgo era tutt’altro che un “paese fantasma” rappresentando un fiorente centro economico per tutta l’area circostante. l’epoca bizantina per Pentedattilo ha rappresentato l’inizio di un declino causato dai continui saccheggi da parte dei saraceni. A seguito della conquista dei normanni per volere del Re Ruggiero d’Altavilla il paese divenne uno dei possedimenti della famiglia Abenavoli. Nel 1783 ci fu il terremoto, che devastò gran parte del territorio reggino, di cui alcuni abitanti usarono alcune macerie del castello per poter rinforzare le abitazioni. Il terremoto ed alcune scosse di quell’anno contribuirono all’allontanamento degli abitanti stessi. negli anno ’90 Pentedattilo incominciò ad essere popolato grazie all’aiuto di alcuni volontari che avviarono un lento percorso di recupero cosicchè ha portato il borgo ad essere un centro artistico e culturale di notevole valore. Il barone di Montebello, Bernardo Abenavoli e la famiglia degli Alberti sono i protagonisti della famigerata “strage degli Alberti “ da cui derivano le storie e leggende che avvolgono ancora oggi Pentedattilo. I protagonisti di questa storia sono due giovani innamorati di due famiglie, di cui non scorre buon sangue. Si racconta che tra la famiglia Alberti, marchesi di Pentedattilo, e la famiglia Abenavoli marchesi di Montebello Ionico, vi era una rivalità per questioni legate ai confini comuni. nel 1680, il Vicerè di Napoli desiderava che nelle zone regnasse pace, ma la tensione tra le due famiglie andava scemando. Il capostipide della famiglia Abenavoli, Bernardino, aveva intenzione di prendere come moglie la figlia della famiglia Alberti, Antonietta, di cui si era innamorato e di cui aveva il suo amore corrisposto. Il Marchese Domenico Alberti aveva promesso la mano della propria figlia a Bernardino Abenavoli solamente quando essa avesse raggiunto l’età per il matrimonio. Alla morte del Marchese Domenico, poco prima della morte, del padre gli succedette al figlio Lorenzo di sposare la figlia del Vicerè di Napoli Caterina Cortez. Fu in occasione del matrimonio il Vicerè di Napoli accompagnato dalla moglie, con la futura sposa e il fratello Don Petrillo Cortez che Don Petrillo trattenutosi per il matrimonio a causa della sua malattia ebbe modo di conoscere Antonietta e di innamorarsene, chiese quindi Lorenzo di poter sposare Antonietta e il Marchese Alberti consentì le nozze, non tenendo in considerazione la promessa del padre al barone Bernardino. Il Barone, venuto a conoscenza del matrimonio tra Don Petrillo e Antonietta, si vendicò contro la famiglia Alberti. La notte di pasqua il 16 aprile 1686, grazie al tradimento di Giuseppe Scrufari, servo infedele della famiglia Alberti, riuscì a introdursi nel castello arrivando alla camera di Lorenzo e lo uccisero, addirittura i suoi uomini andarono in altre stanze uccidendo un bambino di soli nove anni nonchè fratello di Antonietta. Da questa sanguinosa strage vennero risparmiati Caterina Cortez, Antonietta Alberti, la madre Donna Giovanna e don Petrillo Cortez. Quest’ultimo fu preso come garanzia contro eventuali ritorsioni da parte del Vicerè di Napoli. Dopo la strage, Bernardino portò Antonietta al castello a Montebello e la sposò il 19 aprile 1686. ll Barone di Montebello grazie a vari espedienti, riuscì a fuggire con Antonietta, e dopo averla rinchiusa in un convento a Reggio Calabria, scappò prima dai cugini a Brancaleone e poi salpò per Malta dove trascorse qualche periodo per poi dirigersi a Vienna dove si arruolò nell’esercito Austriaco. Bernardino trovò la morte in battaglia nell’agosto del1692 mentre Antonietta, cui matrimonio venne sciolto dalla sacra rota in quanto contratto per effetto di violenza, finì i suoi ultimi istanti di vita rinchiusa in un convento addolorata e triste perchè si era resa conto che era stata lei la causa per la fine della sua famiglia.
Si dice che nelle notti tempestose, dalle guglie del monte dove insisteva il complesso del castello, si odono delle urla, e una mano insanguinata ancora sia visibile tra le rocce che sovrastano l’area del castello.
Brancaleone (RC) i saraceni dell’antico castello di Capistrello

A Brancaleone esiste un antico maniero chiamato Capistrello (posto sull’altra sponda del torrente Altalìa che separa le colline di Pressocito e Brancaleone. Si racconta infatti, che in questo luogo i Saraceni convivessero pacificamente con gli indigeni locali e che questo castello che fosse collegato da un ponte sospeso che lo collegava all’ antica “Sperlinga” (ovvero Brancaleone), questo ponte veniva costruito di giorno e distrutto di notte per paura che i saraceni saccheggiassero Brancaleone. Una notte di tanti secoli fa, questi saraceni si recarono in paese per compiere razzìa, credendo fosse Pasqua, ma avendo sbagliato settimana e non trovando nulla da saccheggiare tornando indietro a Capistrello urlando sconsolati alle loro donne questa frase: “scucinè scucinè ca non è pasca, ma è iornu i frasca” che tradotto starebbe a significare “non cucinate, che oggi non è Pasqua me giorno delle Palme”.
Bova (RC) L’impronta della Regina ed il tesoro del castello

Nell’antico borgo di Bova esiste un castello Normanno scavato sulla roccia le fonti descrivono di un imponente castello fondato in epoca normanna e potenziato nel 1494 dagli Aragonesi. Il castello era costruito su una roccia e gli ambienti ancora esistenti era fatti su tre livelli di cui al piano inferiore c’era un grande “salone” al quale si accedeva attraverso un lungo corridoio al piano superiore due stanze e ancora più in alto vi era una cappella rettangolare e coperta con volta a botte e affrescata, di cui ancora oggi rimangono le tracce. Intorno al castello sono nate diverse leggende, si narra infatti che tra le rovine del maniero, si trova l’orma del piede di una donna che la leggenda vuole sia appartenuto alla Contessa Matilde di Canossa, e che se l’orma di una fanciulla corrispondesse alla stessa, questi avrebbe scoperto di discendere da questa nobile stirpe. Un’altra leggenda parla dell’orma della Regina e diceva se il piede di una fanciulla avesse combaciato perfettamente a quello della Regina la roccia si sarebbe aperta, facendogli scoprire un tesoro, protetto da un grande serpente, di cui su una di queste rocce che caratterizzano l’area del castello è rimasta una traccia incisa.
San Giorgio Morgeto (RC): Il Re Morgete, la Scala Beffarda e le Jovisse

Fiore all ’occhiello della provincia di Reggio Calabria, il borgo medievale di San Giorgio Morgeto resta tra i più caratteristici dell’entroterra calabrese, distintivo di una cultura, una storia da scoprire e da vivere; il profumo di tradizione e bellezza che si diffonde tra le vie antiche, i palazzi e i monumenti, la fierezza negli occhi della gente del posto, innamorata di questo piccolo paradiso culturale, sono ragione di orgoglio non solo per la provincia reggina, ma per l’intera regione. Maestoso e imponente, sulla cima del colle di San Giorgio Morgeto, regna sul paese e le valle sottostanti il Castello Normanno di Re Morgete, finestra su un panorama mozzafiato sulla piana del Tauro, con una vista che dal Monte Sant’Elia spazia fino a Capo Vaticano e che, nelle giornate più favorevoli, consente di intravedere in lontananza anche le isole Eolie. I ruderi di quella che era una possente fortificazione, sono stati e tutt’oggi sono sfondo di inquietanti e sconvolgenti leggende che gli anziani del luogo raccontano; una in particolare narra di come il Re Morgete, che in seguito alla sua morte veniva adorato come Dio, apparisse dal luogo della sua sepoltura ogni giorno, allo scoccare della mezzanotte, esclusivamente al popolo di Morgeto per predire eventi futuri. Una diversa versione narra che il Dio, dispensatore di oracoli, manifestasse le sue visioni da interpretare tra le mura del castello, al lume di fiaccole o della luna piena.
 Non molto distante dalla chiesa dell’Assunta, si giunge in una delle particolarità urbanistiche medievali di San Giorgio Morgeto; Conosciuta con il nome “Scala Beffarda” essa è un particolare esempio di scalinata sfalsata e davvero singolare. Per la sua caratteristica unica nel suo genere, numerose leggende aleggiano attorno a questa scalinata che spesso sembra di percepire attraverso gli spifferi d’aria che tra gli stretti vicoli narrano storie e leggende incredibili.
Non molto distante dalla chiesa dell’Assunta, si giunge in una delle particolarità urbanistiche medievali di San Giorgio Morgeto; Conosciuta con il nome “Scala Beffarda” essa è un particolare esempio di scalinata sfalsata e davvero singolare. Per la sua caratteristica unica nel suo genere, numerose leggende aleggiano attorno a questa scalinata che spesso sembra di percepire attraverso gli spifferi d’aria che tra gli stretti vicoli narrano storie e leggende incredibili.
Altra suggestiva leggenda riguarda le “Jovisse” (leggiadre figlie di Giove), che potevano vedersi aggirare tra i boschi intorno alla fortezza o per le stanze dell’antico maniero, mandando in confusione chiunque li avesse incontrate.
San Luca (RC) La leggenda della Principessa Atì
 La leggenda del castello di Atì nasce sulle sponde orientali del mar Ionio, nella zona di San Luca (Pietra Castello. Qui, infatti, si notano distintamente le rovine di quello che fu l’antico castello di Atì. Questa fu fatto costruire da un Conte della città di Potamìa, distrutta da un violento terremoto nel ‘300, che aveva un carattere davvero scontroso ed arrogante. A causa dei suoi atteggiamenti, il conte si era fatto tanti nemici nella sua città. L’ennesimo litigio con un concittadino, però, finì male e quest’ultimo rimase ucciso. Per sfuggire alla vendetta dei parenti della vittima, così, il conte si costruì questo grande castello, dove si trasferì con la bellissima figlia Atì, che al contrario del padre aveva un carattere mite e amichevole ed un suo paggio, che dilettava i suoi padroni con le sue poesie e la musica del suo liuto. Il castello, costruito in un luogo praticamente inaccessibile, era dotato di un grande mulino a vento e di una cisterna per l’acqua piovana, permettendo ai suoi abitanti di rimanervi rinchiusi senza il pericolo di rimanere sprovvisti di cibo. Fra le mura del castello il conte smise di preoccuparsi dei suoi nemici, che pure di tanto in tanto giungevano nei pressi del ponte levatoio, costantemente chiuso, per urlargli cattive parole e per lanciare sassi e frecce contro le impenetrabili pareti della fortificazione. Il paggio e la dolce Alì, invece, anche a causa dell’isolamento dalla vita esterna, passavano molto tempo insieme e finirono per innamorarsi. I due cominciarono a vedersi in segreto, poiché lo spocchioso conte mai avrebbe concesso la mano della nobile figlia al modesto servo. I nemici del conte, tuttavia, erano sempre in agguato fuori dalle mura e per caso sentirono i canti innamorati che il paggio dedicava ad Atì. Così, dopo vari tentativi, riuscirono a far arrivare un messaggio al paggio in cui gli promettevano di eliminare il conte, che avrebbe sempre osteggiato il suo amore per Atì, se il ragazzo avesse fatto trovare loro il ponte levatoio abbassato. Il ragazzo, sdegnato, non ci pensò minimamente a tradire il suo padrone. Ma i giorni passavano e nel suo cuore cresceva l’insofferenza per un amore che doveva rimanere celato. Così un giorno compose una ballata religiosa che aveva come tema il tradimento di Giuda. I nemici del conte, incuriositi, accorsero alle mura e ricevettero un messaggio del giovane. Durante la notte del successivo venerdì, infatti, avrebbe cantato un verso che recitava le seguenti parole: «E disse Cristo agli Apostoli suoi, quando volete entrare sta solo a voi». Dopo aver recitato quelle parole, il paggio avrebbe abbassato il ponte, permettendo ai nemici del conte di entrare nel castello. Arrivati al venerdì successivo, il ragazzo così fece, finendo però nella trappola degli invasori che, oltre al conte, rapirono anche lui. Ma quando costoro andarono a cercare Atì, tuttavia, trovarono solo la sua stanza vuota. Sulla sua scrivania notarono una candela che illuminava il Vangelo, che era aperto alla pagina in cui san Matteo racconta il tradimento di Giuda. Delusi e arrabbiati, decisero di gettare il conte e il paggio giù dal dirupo per poi incendiare il castello. Della giovane Atì, invece, non si seppe più nulla. Molti pastori della zona, però, sono sicuri di aver intravisto nelle notti, una giovane e bellissima donna avvolta da un velo tra le rocce della scogliera. Dal fondo del burrone, invece, sorgerebbero ancora le grida dei fantasmi del conte e del paggio, che pagarono con la vita gli sbagli commessi in vita.
La leggenda del castello di Atì nasce sulle sponde orientali del mar Ionio, nella zona di San Luca (Pietra Castello. Qui, infatti, si notano distintamente le rovine di quello che fu l’antico castello di Atì. Questa fu fatto costruire da un Conte della città di Potamìa, distrutta da un violento terremoto nel ‘300, che aveva un carattere davvero scontroso ed arrogante. A causa dei suoi atteggiamenti, il conte si era fatto tanti nemici nella sua città. L’ennesimo litigio con un concittadino, però, finì male e quest’ultimo rimase ucciso. Per sfuggire alla vendetta dei parenti della vittima, così, il conte si costruì questo grande castello, dove si trasferì con la bellissima figlia Atì, che al contrario del padre aveva un carattere mite e amichevole ed un suo paggio, che dilettava i suoi padroni con le sue poesie e la musica del suo liuto. Il castello, costruito in un luogo praticamente inaccessibile, era dotato di un grande mulino a vento e di una cisterna per l’acqua piovana, permettendo ai suoi abitanti di rimanervi rinchiusi senza il pericolo di rimanere sprovvisti di cibo. Fra le mura del castello il conte smise di preoccuparsi dei suoi nemici, che pure di tanto in tanto giungevano nei pressi del ponte levatoio, costantemente chiuso, per urlargli cattive parole e per lanciare sassi e frecce contro le impenetrabili pareti della fortificazione. Il paggio e la dolce Alì, invece, anche a causa dell’isolamento dalla vita esterna, passavano molto tempo insieme e finirono per innamorarsi. I due cominciarono a vedersi in segreto, poiché lo spocchioso conte mai avrebbe concesso la mano della nobile figlia al modesto servo. I nemici del conte, tuttavia, erano sempre in agguato fuori dalle mura e per caso sentirono i canti innamorati che il paggio dedicava ad Atì. Così, dopo vari tentativi, riuscirono a far arrivare un messaggio al paggio in cui gli promettevano di eliminare il conte, che avrebbe sempre osteggiato il suo amore per Atì, se il ragazzo avesse fatto trovare loro il ponte levatoio abbassato. Il ragazzo, sdegnato, non ci pensò minimamente a tradire il suo padrone. Ma i giorni passavano e nel suo cuore cresceva l’insofferenza per un amore che doveva rimanere celato. Così un giorno compose una ballata religiosa che aveva come tema il tradimento di Giuda. I nemici del conte, incuriositi, accorsero alle mura e ricevettero un messaggio del giovane. Durante la notte del successivo venerdì, infatti, avrebbe cantato un verso che recitava le seguenti parole: «E disse Cristo agli Apostoli suoi, quando volete entrare sta solo a voi». Dopo aver recitato quelle parole, il paggio avrebbe abbassato il ponte, permettendo ai nemici del conte di entrare nel castello. Arrivati al venerdì successivo, il ragazzo così fece, finendo però nella trappola degli invasori che, oltre al conte, rapirono anche lui. Ma quando costoro andarono a cercare Atì, tuttavia, trovarono solo la sua stanza vuota. Sulla sua scrivania notarono una candela che illuminava il Vangelo, che era aperto alla pagina in cui san Matteo racconta il tradimento di Giuda. Delusi e arrabbiati, decisero di gettare il conte e il paggio giù dal dirupo per poi incendiare il castello. Della giovane Atì, invece, non si seppe più nulla. Molti pastori della zona, però, sono sicuri di aver intravisto nelle notti, una giovane e bellissima donna avvolta da un velo tra le rocce della scogliera. Dal fondo del burrone, invece, sorgerebbero ancora le grida dei fantasmi del conte e del paggio, che pagarono con la vita gli sbagli commessi in vita.
Samo (RC) Il brigante “Nino Martino” detto il “Cacciadiavoli”

Vissuto nel ‘500, se ne contendono i natali e le gesta sia la provincia di Reggio che quella di Cosenza (anche se le ragioni di Reggio sono storicamente maggiormente fondate). Nino Martino fu talmente celebre che intorno alla sua figura fiorirono storie, ballate e racconti, come ad esempio una celebre ballata in dialetto silano. Brigante buono e generoso, leale e coraggioso, colui il quale vendicò i torti della gente e divenne a causa di ciò “santo”: per questo era ovviamente lo spauracchio dei nobili calabresi. Dopo anni passati fra le montagne, stanco di quella vita di pericoli e sangue, decise di tornare nel paese natìo, anche per poter riabbracciare la madre, da anni abbandonata ed odiata da tutti perché madre di un brigante. Un giorno, però, sentì la predica di un frate, e, raccolti i suoi compagni, li esortò a deporre le armi e si ritirò in un luogo solitario fra le montagne, suscitando dapprima l’incredulità e successivamente il dubbio dei suoi compagni (che erano per altro consci del fatto che non sarebbero potuti entrare nel paese senza l’aiuto delle armi), i quali lo raggiunsero e lo denunciarono ai nobili che gli si lanciarono addosso crivellandolo a morte; coprirono poi il suo corpo con dei sassi e lo abbandonarono. La notizia della morte di Nino corse molto velocemente e giunse sino alle orecchie della madre che, profondamente affranta, andò con i nobili a recuperare sui monti il cadavere del figlio. Rimosse con le sue mani il mucchio di sassi e, come per incanto, trovò il corpo del suo figliolo ancora intatto, bello e roseo, come se fosse addormentato: le ferite sembravano petali di fiori, il suo volto calmo e rassegnato in un’espressione di pace eterna. Il corpo fu poi condotto presso la casa della madre che non ebbe però il coraggio di seppellirlo e lo depose così sotto la grande botte della sua cantina, per poterlo vedere sempre. Dopo dei mesi che il cadavere era stato posto lì, un giorno, la povera donna, non riuscì a spostare la botte e ne rimase profondamente sorpresa, poiché quell’anno non aveva fatto vino; in seguito l’aprì e notò che da essa zampillava invece un ottimo vino, che subito distribuì a chiunque lo richiedesse; notò poi che tale botte si riempiva costantemente, quasi fosse una fontana. Era tuttavia amareggiata, perché non poteva più vedere il volto del figlio, nascosto dietro la botte. Fece dunque chiamare un bottaio per far togliere il tappo della botte e capire quanto vino contenesse: uno spettacolo meraviglioso si presentò agli occhi del bottaio e della vecchia madre: in fondo alla botte era disteso, fresco e intatto, come se dormisse, il corpo di Nino Martino e da una delle sue ferite vicino al cuore era nata una pianta di vite che egli alimentava col suo sangue. Portava sui tralci una miriade di grappoli sempre maturi che si rinnovavano tutte le volte che la donna spillava il vino. Fu a causa di ciò che a Nino Martino venne in seguito dato l’appellativo di “Santo”, il santo dell’abbondanza, invocato dalla gente quando si calpestano i grappoli dell’uva, perché, attraverso il suo sangue, faccia avere abbondanza del prezioso liquido.
Palmi (RC) La leggenda di Donna Cànfora
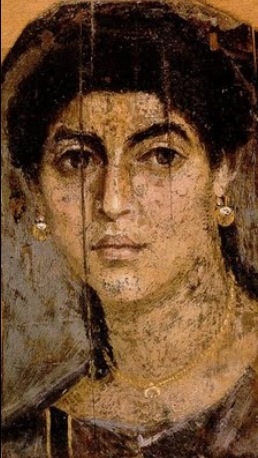
Donna Cànfora gentildonna ricchissima, adorna delle più gentili virtù e di suprema bellezza. Amica fortuna l’aveva colma di beni: le sue vigne versavano ogni anno vino a flutti nelle ampie bigonce; su’ suoi campi sterminati biondeggiava sempre abbondante la messe; e lana e latte e burro le mandavano i prati della montagna, che nutriva per lei numerose mandrie di buoi e di capre. Di tanta ricchezza Donna Cànfora, tra le cui virtù fioriva grande la carità, teneva per sé il necessario e dispensava ai poveri il superfluo. Sicché dalla sua casa, benedetta da Dio, salivano le benedizioni dei miseri sfamati, delle fanciulle povere strappate da lei al disonore, dagl’infermi, ai quali mandava il vino più generoso delle sue cantine e la tela più fine delle sue casse. La fama di tanta carità volò per quella contrada e per altre ancora, e con essa la fama della bellezza di Donna Cànfora. Giacché, alta, dal profilo purissimo, dalle forme flessuose, circonfusa da un’intensa vita spirituale, piena di grazia e dignità, pareva ella uscita dallo scalpello di Prassitele. Si estese, dunque, così la fama, che schiere di poveri pellegrini picchiavano alla sua porta, mentre invano lanciavano su di lei frecce di amore legioni di cavalieri da lontani paesi a bella posta venuti. Non già che Donna Cànfora avesse cuore deserto di affetti, ché anzi era stata moglie amorosa, e la vita del marito aveva resa felice e con le grazie del corpo e più con la soavità dell’anima. Rimasta vedova, ella, giovanissima ancora, consacrò la fiorente bellezza alla memoria dell’infelice consorte. E a molti, i quali invaghiti di lei o delle sue ricchezze, la chiedevano in isposa, ella rispondeva, ragionando essere uno il marito dato alla donna da Dio, e a quell’uomo doversi ogni donna mantenere unita in ispirito; giacché, se i corpi muoiono e si disuniscono, non così gli spiriti, che sono immortali, e l’uno quindi non si distacca mai dall’altro. Sparsasi dovunque la nuova di così bella fedeltà, crebbe in tutti gli animi l’ammirazione già grande per donna tanto virtuosa; e dalle madri Donna Cànfora era additata per esempio alle figliuole e dai mariti alle mogli. Un giorno la cameriera di Donna Cànfora rincasò con una bella notizia. Era giunta dall’oriente una nave carica di seriche stoffe, di grosse gemme, di piume candide come la spuma del mare, di pelli, di tappeti rarissimi, di maioliche stupendamente dipinte. Tutti, patrizi e plebei correvan giù alla marina, per ammirare tanta dovizia di cose belle, esposte sulla corsìa della nave, alle murate, agli alberi, a prora, a poppa, dovunque, fra mille vivi colori.
– Son meraviglie, – diceva la cameriera a Donna Cànfora, la quale aveva abbandonato l’arcolaio per ascoltarla, – meraviglie che si vedono una volta sola nella vita. Andiamo, signora; troverete laggiù le vostre amiche, ché tutte sono accorse. Su, voglio vestirvi subito subito, venite…
Ma Donna Cànfora era assai triste quel giorno; aveva brutti presentimenti.
-Stamane, – disse – l’arcolaio cigolava troppo. Che ne dici? Non è un avviso del Signore?
Ma che dite?? L’arcolaio è unto da pochi giorni. E’ mai possibile che cigoli? E poi che avviso! Di che?
– Non so… – riprese a dire Donna Cànfora – mi batte il cuore; e più volte mi è paro di vedere qui, dinanzi a me, lui, il povero mio marito. Che sarà mai? Certo non bene…Io sento…come se dovessi morire.
Prima di uscire Donna Cànfora volle visitare tutta la casa; poi pregò inginocchiata la Madonna; sull’uscio si rivolse per dare alla pace, che abbandonava, un ultimo sguardo e finalmente si avviò sospirando. Sulla riva del mare, infatti, gran folla. La quale, appena Donna Cànfora comparve, si divise in due ali, per farvela passare in mezzo come un’amata regina. Il capitano della nave le andò incontro con viso sorridente, e le disse: La fama della vostra virtù, o madonna, giunse fino ai lidi più lontani dell’Arabia e della Persia, e la vostra visita, da noi aspettata, c’è premio, del quale non sappiamo come ringraziarvi. Donna Cànfora, cui il cuore palpitava sempre più forte, ringraziò e si lasciò guidare fin sulla tolda. Le magnificenze narrate dalla cameriera, rimasta sulla riva tra la folla, eran vere; ed ella andava ammirandole ad una ad una, accompagnata dal gentile capitano. A un tratto i sostegni si rompono, e la nave scivola sul mare: i remi son pronti, i rematori al loro posto, e la nave fila diritta come una freccia. Dalla riva s’alzano grida furibonde, imprecazioni disperate, e cento giovani gagliardi si slanciano nelle onde, per raggiungere a nuoto i finti mercanti, gli esecrati corsari. La patria si allontanava, circonfusa in un pulviscolo dorato, e il tumulto della spiaggia più non si udiva. Donna Cànfora pareva serena: un’aria di dignitosa rassegnazione era sparsa sul suo viso pallido. Chiese in grazia di esser lasciata libera un istante, per dare l’ultimo saluto alla terra natale; e diritta sulla poppa, gli occhi profondi e lucenti, guardava le curve delle montagne baciate dagli ultimi raggi del sole presso al tramonto. La brezza vespertina folleggiava con la candida veste, coi riccioli neri cadenti sulla fronte severa. Donna Cànfora guardò, guardò a lungo. Poi, sollevati gli occhi al cielo, come per chiedere perdono al Signore, si lanciò fra le onde. Il capitano della nave non ebbe il tempo di gridare e di accorrere, che già ella, abbracciata dal nuovo sposo, il mare, scomparve senza un lamento, senza un singulto.
Motticella di Bruzzano Zeffirio (RC) La leggenda della Rocca di San Fantino

Ci troviamo a Motticella piccola frazione di Bruzzano Zeffirio, dove vi abitano poco più che una manciata di abitanti per lo più anziani che si dedicano ancora con tanta passione e determinazione alla pastorizia e all’agricoltura. Il borgo sull’orlo del torrente Bampalona o Torno è dominato dal maestoso il Monte Scapparone (1058 mt s.l.m.). Proprio nelle vicinanze del paese, alle pendici del monte Fasoleria nel comune di Ferruzzano, vi è una località chiamata San Fantino.
La località è caratterizzata da un monolite di arenaria che si erge come un dito in uno scenario davvero unico al mondo, non distante dai resti medievali di chiese bizantine e antiche chiesette che costellano il territorio di Bruzzano Zeffirio. Si racconta che in località “Junchi” tra i paesi di Motticella e Ferruzzano, nelle vicinanze della “rocca di san fantino” vivesse un frate eremita di nome Phentino o Phantino, esperto nelle pratiche mediche delle piante medicinali e agricole, tanto che le genti del luogo spesso ricorrevano a lui per consigli relativi alle semine, potature, innesti ed tanto altro. A Mottticella viveva una bellissima ragazza di nobile famiglia, come in tutte le storie di paese pare che questa ragazza avesse un amante segreto per il quale il padre non fosse d’accordo alla relazione. un giorno la ragazza si accorse di essere in attesa di un figlio, certa che il padre non sarebbe stato contento decise di tenere nascosta la gravidanza. Un giorno si recò presso questo frate eremita a chiedere consigli, insieme convennero che poco prima del parto la ragazza si sarebbe recata presso il piccolo asceterio con la scusa che sarebbe andata a trovare alcuni perenti in un paese lontano da Motticella. e così accadde, la ragazza partorì un bel bambino, rimase con il frate per più di un mese finche’ il bambino non cominciò a nutrirsi di latte di capra. di tanto in tanto la donna si recava di nascosto sul luogo a trovare il bambino che cresceva sempre più bello. un giorno il bambino si ammalò, forse di bronchite, ed il frate non riuscì a curarlo con le sue erbe tanto che di li a poco il bambino morì. A questo punto il frate disperato per l’accaduto si recò in cima alla rocca, pose il corpicino senza vita del bambino sulla cima e si mise a pregare pregare e pregare tanto con tutta la sua forza e tutta la sua fede, sperando in un miracolo divino. pregando e pregando si addormentò, e durante il sonno corvi e cornacchie mangiarono il corpicino del povero bimbo. Il frate al suo risveglio fece la macabra scoperta. Dopo alcuni giorni la ragazza si recò nuovamente a trovare il figlio, ma giunta da frate venne a conoscenza dell’orribile fine e in preda al dolore si avventò sul frate percuotendolo con forza fino a mordergli il naso. la donna ritornò a casa piangendo disperata, tanto che per il dolore diventò matta. infatti la famiglia della donna fu costretta a rinchiuderla in una stanza della casa senza finestre ) in pratica una cella, dove la ragazza vi rimase fino alla sua morte. Il frate invece, a causa dell’infezione del morso sul naso di li a poco morì anche lui. Sembra proprio che la rocca, nasconda un tesoro, e che pare fosse stato nascosto proprio da fra Phantino. Pare anche che che fosse un serpente (o un demone) a proteggerlo. La leggenda vuole che, per poter entrare in possesso di questo tesoro bisogna recarsi sulla rocca in una notte di luna piena con un neonato per sacrificarlo al serpente, uccidendo il bimbo e cucinarlo in una pentola mai usata prima, a questo punto, il serpente dovrebbe aprire la rocca lasciando accesso a questo tesoro, contenuto in un pentolone di rame colmo di monete d’oro e diamanti e rubini.
Roghudi (RC) Le Anarade ed il Drago

Tra le tante leggende che vengono tramandate dagli anziani di Roghudi ve n’è una che racconta la storia di particolari donne con i piedi a forma di mulo, che risiedevano di fronte al loro borgo, nella contrada “Ghalipò” e chiamate Anarade. Le Anarade, riposavano durante il giorno e di notte, a cavalcioni di un ramo di sambuco, andavano alla ricerca di uomini per accoppiarsi. Erano infatti solite modificare la loro voce, assumendo per esempio quella di un congiunto delle loro vittime. Cercavano di attirare le donne roghudesi che si recavano alla fiumara per lavare i panni, con l’intento di ucciderle e avere così i loro uomini. Gli abitanti del paese decisero allora, di chiudere il paese con tre cancelli sistemati in tre differente entrate, per proteggersi dalle Anarade, i cancelli sono tutt’oggi esistenti e sono quelli di Pizzipiruni, Plachi e Agriddhea. Non molto distante da Roghudi, sorge la frazione di Ghorio di Roghudi, anche questa completamente abbandonata. La caratteristica di questa frazione è rappresentata da un particolare masso da una forma particolare , nota come a Rocca tu Draku, il cui significato risale al termine ellenistico Draku che vuol dire occhio. Secondo le leggende di Roghudi, infatti, si tratterebbe della testa di un drago che sul colle custodiva un tesoro inestimabile. vicino la pietra della testa del drago è presente un’altra roccia particolare a forma di groppe. Secondo le credenze popolari si trattava delle sette caldaie o caddareddhi che permettevano al drago di nutrirsi. Il tesoro custodito dal drago, secondo le leggende di Roghudi, veniva assegnato soltanto a un combattente coraggioso, capace di superare una prova. Il cavaliere per poter ottenere il tesoro del drago doveva sacrificare tre esseri viventi maschio: un neonato, un capretto e un gatto nero. Nessuno ebbe mai il coraggio di sfidare il furioso drago fin quando un giorno venne alla luce un bambino con delle malformazioni, che venne affidato a due uomini affinché se ne sbarazzassero. Cosi i due uomini, pensando alla vecchia leggenda, decisero di prepararsi alla prova di coraggio per il sacrificio e ottenere il tesoro del drago. L’altare era pronto e il gatto e il capretto erano già stati sacrificati. Nel momento in cui stavano per uccidere il bambino, una violenta e improvvisa tormenta di vento scaraventò i due uomini contro le caldaie del drago, uccidendo uno dei due. In seguito nessuno osò sfidare il drago mentre l’uomo sopravvissuto visse in tormenta del diavolo fino alla fine dei suoi giorni.
PROVINCIA DI COSENZA:
Cosenza: U crucifissicchiu di Cosenza

Nella zona Arenella, a Cosenza, lungo il fiume Crati, si trova una chiesetta detta “U Crucifissicchiu”: il piccolo crocifisso, dove si venera un’impronta di una croce su una pietra posta sull’altare. Un giorno, una donna raccolse dal letto del fiume una pietra e se la portò a casa per i suoi domestici. La notte le venne in sogno Gesù e le disse di riportare la pietra nel luogo in cui era stata raccolta e di erigere una chiesetta in quel punto. Al mattino, la donna si accorse che sulla pietra era presente l’impronta di un crocifisso, segno che non era presente al momento della raccolta. La notizia fece il giro di Cosenza e si iniziò la costruzione della chiesa, dove sopra l’altare fu posta la pietra del crocifisso. Dal giorno della consacrazione della chiesa, mai, straripando, il fiume allagava la chiesa, limitandosi solo a lambire il piccolo edificio. Solo in un’occasione, una grande piena entrò nella chiesa, ma al calare delle acque, i fedeli trovarono accesa la lampada situata vicino al crocifisso, e nonostante la patina del fango segnasse che la piena era arrivata fino al soffitto, la lampada ardeva ancora e il crocifisso era pulito.
San Sisto dei Valdesi (CS): la leggenda di Marco Berardi

La storia di Marco Berardi è considerata da sempre molto affascinante. Risuonò attraverso i boschi della Sila, tramandata da padre in figlio, cantata da poeti e menestrelli, giungendo fino ai giorni nostri. “Giovane popolano, ma dall’ingegno eletto e di cuore caldo di amore patrio, e non amò in vita che la libertà, l’indipendenza, la grandezza vera della Calabria; non odiò che gli Spagnuoli, i Baroni, gl’Inquisitori. Inoltre, “Marco aprì il suo cuore ad una giovane valdese di San Sisto, figlia di Valdesi forse residenti nella località “Guardia” o nei suoi pressi” , e come vedremo poi, “ Fu proprio l’amore per questa fanciulla a spingerlo a essere consigliere e guida di questi Valdesi della contrada “Guardia” che, per primi si ribellarono alle imposizioni dell’Inquisizione e che uccisero, persuasi e diretti da Marco Berardi, il Governatore di Montalto il “Barone de Castagnedo”. La rivolta di questo gruppo di Valdesi determinò la reazione della regia Corte e della Santa Inquisizione, che culminò con la cosiddetta “Crociata del Querceto” e l’eccidio dei Valdesi di San Sisto. Marco Berardi viene rappresentato nella storiografia come un uomo forte e coraggioso, difensore dei deboli. Egli era diventato un brigante non per avidità, ma per sete di giustizia. Dopo l’assassinio del Barone de Castagnedo, Marco Berardi fu fatto prigioniero, torturato e condannato ad essere arso al rogo. Con modalità ancora non note, Berardi riuscì ad evadere dalla prigionia ed a fuggire nei boschi con l’aiuto di alcuni abitanti di San Sisto e si diede alla macchia per i boschi della Sila dove radunò un esercito sempre più numeroso. Nel 1562 assunto il nome di Re Marcone riuscì a liberare tutti i paesi della presila dal dominio Spagnolo. Egli sognava di fondare una Repubblica Calabrese, con capitale Crotone, libera dal dominio spagnolo e dalla Santa Inquisizione, che avevano oppresso e causato lutti tra la sua gente. Nel 1563 tentò di conquistare la città di Crotone, combattendo contro l’esercito del Marchese di Cerchiara e, nonostante il suo esercito fosse numericamente inferiore, riuscì a sconfiggerlo per tre volte. Fu scomunicato e sulla sua testa fu posta una taglia per fare in modo che venisse abbandonato dai suoi seguaci. La strategia dei suoi nemici risultò vincente, sfuggito al tradimento del suo migliore amico, con un numero di fedelissimi sempre più esiguo, si perde nella leggenda la vicenda della sua morte. Si narra che i corpi di Marco e Giuditta siano stati ritrovati abbracciati in una grotta della Sila ed il corpo del Re della Sila sia stato portato a Cosenza e issato sul campanile della Chiesa di San Francesco di Assisi per fare da monito a quanti volessero provare nuovamente la via della ribellione. Le sue idee però non sono state fermate e la sua leggenda aleggia ancora oggi nei vicoli di San Sisto e sull’altopiano della Sila.
(Fonte: DeaKalabria)
Cardinale (CS) La Baronessa Maria Erichetta Scoppa

Nel cuore delle Serre calabresi, a poco più di mille metri d’altezza, c’è un luogo misterioso e spettrale, e la storia legata a questo castello ha qualcosa ai confini fra verità e leggenda si tratta di Maria Enrichetta Scoppa, Baronessa di Badolato, ricca proprietaria terriera realmente esistita a cavallo fra Otto e Novecento. Oggi ciò che resta del Castello della Lacina, è un piccolo e affascinante maniero di origini cinquecentesche ormai in stato di rudere, ubicato in una zona chiamata “Chianu da Jannara”, nel territorio di Cardinale (Catanzaro). Si racconta inoltre che nei pressi del Castello ci fosse una chiesetta, forse sorta su un antico tempio rurale intitolato alla dea greca Hera Lacinia (venerata nel grande santuario di Capo Colonna, a Crotone), il che forse spiegherebbe il toponimo Lacina, ma in realtà del presunto tempio, non c’è alcuna traccia. Da oltre un secolo una leggenda locale ha reso la Baronessa Scoppa protagonista di vicende degne del famigerato Gilles de Rais. La Baronessa “storica”, nata nel 1831 e morta nel 1910, è in realtà nota alle cronache come una donna nubile di fervente religiosità che viveva nel borgo di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) dove nel 1897 fece costruire il collegio e la chiesa della Congregazione del Santissimo Redentore, supportò diversi seminaristi, elargì doti a fanciulle povere, fece restaurare la chiesa madre e l’acquedotto di Niforio e lasciò il palazzo di famiglia in eredità alle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, con l’impegno di fondarvi un Orfanotrofio. Tuttavia la leggenda le attribuisce un lato oscuro che proprio nel Castello della Lacina, indicato come sua residenza estiva, avrebbe trovato efferato sfogo. Si racconta infatti che la nobildonna, sebbene da giovane avesse fatto voto di verginità, andasse segretamente alla continua ricerca di esperienze erotiche e che allo scopo attirasse nel suo castello fra i boschi giovani e prestanti uomini dei dintorni con cui consumava torridi rapporti carnali, i suoi occasionali amanti pare venissero fatti puntualmente sparire nelle sabbie mobili presenti nel territorio circostante, affinché non rimanesse traccia delle inconfessabili abitudini della donna. Infatti pare che nei paraggi vi sarebbero delle zone paludose coperte di giunchi secchi, dette nel dialetto locale vizzichi o uocchie e mare, perché si credeva fossero in comunicazione col Mar Jonio. Si racconta che un tempo nell’area ci fossero colture di grano e che quindi non fosse raro il passaggio di carri trainati da buoi, a taluno dei quali pare sia capitato di finire risucchiato in queste subdole torbiere. Per la cronaca la sua fu dunque una vita da ricca latifondista, oltre che da donna afflitta da una esasperante forma esteriore di devozione religiosa, come tale vissuta fino a quel febbraio 1910 quando spirò a Villa Condò, non prima di aver lasciato i suoi beni alla nipote Enrichetta Di Francia, sposa del marchese Armando Lucifero. Una vita a cui si è ispirato il romanzo “La Lacina e il casino della baronessa” della scrittrice calabrese Rosina Andreacchi.
PROVINCIA DI CROTONE:
Le Castella (KR) Annibale e la Madonna sorella di sette.

Moltissime leggende sono legati al grande tempio di Hera Lacinia a Capocolonna, si narra che Tetiche avesse regalato ad Hera il promontorio e il “vago bosco” secondo l’espressione di Timeo; quello di suo figlio Achille in memoria dal quale le donne crotoniati usavano vestire di nero un giorno all’anno, e recatesi al tempio, manifestavano il loro dolore per la morte del grande Achille “alto nove cubiti”. Altro mito legato al tempio del Lacinio è quello di Elena, di cui, si narra, vi fosse una grande immagine dipinta, che il famoso pittore Zeusi aveva realizzato prendendo a modello le fanciulle crotonesi, la cui bellezza era proverbiale, e ritraendo di ciascuno i particolari più belli. La leggenda intorno al tempio di Hera Lacinia sono innumerevoli: per esempio, si narra che se qualcuno incideva il suo nome su una tegola del tempio, l’iscrizione sarebbe durata fino alla morte dell’uomo che l’aveva scritta, che nel vestibolo del tempio vi fosse un altare le cui ceneri nessun vento poteva smuovere e che Annibale vi avesse dedicata un’ara con l’iscrizione delle sue imprese in caratteri punici e greci. Il nome di Annibale è legato a Le Castella, che anticamente si chiamavano Castra Hannibalis, perché, si tramanda, che in questa località il condottiero cartaginese avesse posto i propri accampamenti e che qua fossero accaduti tragici avvenimenti. Pare infatti, che Annibale, avendo ricevuto da Cartagine l’ordine di ritirarsi, preparava l’imbarco delle sue truppe. Avendo con sé un contigente di mercenari italici e non volendo lasciarli liberi, nel timore che potessero passare al nemico, ordinò loro di accompagnarlo in Africa. Gli Italici si rifiutarono e Annibale, condotti sulla riva, li fece massacrare.
Ancora oggi il mito rivive rielaborato nelle leggende legate ai riti mariani. Una leggenda popolare racconta che la Madonna di Crotone è sorella della Madonna Greca di Isola e che, disperse in vari luoghi, vi sono in tutto sette sorelle. Al di ciò che la tradizione tramanda ed i sentimenti, tela leggenda rammenta senz’altro il mito della Pleiadi, delle sette sorelle diventate poi la costellazione che conosciamo.
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Vibo Valentia; La leggenda di Scrimbia

Scrimbia è una zona della città, nei pressi del Duomo, dove sono stati rinvenuti tantissimi reperti archeologici. Una simpatica leggenda, così narra della Ninfa: “Scrimbia, era una giovane fanciulla ipponiate che non riuscendo a darsi pace per la morte del giovane amante, piangeva ininterrottamente. Gli dei, rattristati e commossi per il continuo suo piangere, la tramutarono in una sorgente di acque fresche ed abbondanti affinché abbeverasse tutta la città”. In suo onore fu costruita una fontana di cui, rimangono solo alcuni pezzi, mal collocati in un arido muro di cemento posto su Via A. De Gasperi . Con la Ninfa Scrimbia si apre il racconto storico scolpito da Giuseppe Niglia nel 1975, sulle porte del Tempo del Duomo della Città. Inoltre, a lei si è ispirato l’artista locale Reginaldo D’Agostino nel realizzare la statua collocata all’interno della vasca che si trova in piazza Martiri d’Ungheria o Piazza Municipio.
Nella seconda versione conosciuta si dice che Scrimbia era una ninfa che scorazzava felice nelle selve attorno ad Hipponion; poi un giorno patì la sventura d’innamorarsi d’un uomo senza essere ricambiata e per lo struggimento cominciò a consumarsi in un pianto senza fine. Gli dei, allora, ne ebbero pietà e siccome era un vero peccato fare andar perse tutte quelle lacrime, la mutarono in una sorgente perenne, quella che una volta scorreva liberamente sulla collina Ipponiate, rendendola ricca di piante sempreverdi, e che poi gli abitanti del centro Magnogreco incanalarono fino ad un fontana, tutt’ora esistente, per sfruttarla come inesauribile risorsa idrica.
I sette martiri di Vibo Valentia

Narrano i cronisti che la mattina dell’8 maggio (altri dicono 8 giugno) del 1508 sette teste umane penzolavano dai merli del castello Normanno di Vibo Valentia e i corpi erano attaccati alle mura. I nomi dei 7 “martiri” (così furono definiti dalla tradizione) sono: Giovanni Recco, Ortensio Recco, G. Battista Capialbi, Domenico Milana, Francesco D’Alessandro, Sante Noplari, Tolomeo Ramolo. Dopo l’eccidio e l’insediamento dei Pignatelli i nobili monteleonesi, in segno di protesta, si trasferirono a Tropea. La leggenda vuole che ogni notte dell’8 giugno fino al giorno in cui i martiri non furono vendicati, scendesse dal castello e percorresse le vie principali della città, un cavallo che lanciava terrificanti nitriti e sprigionava faville dagli zoccoli. Diana Recco, sorella e figlia di due martiri, allora aveva 12 anni essendo nata nel 1498 e dopo il fatto tragico emigrò anche lei con il resto della famiglia a Tropea . Arrivò alla fine il momento della vendetta: donna Caterina Recco, madre di Diana , con la complicità di alcuni nobili monteleonesi trapiantati a Tropea, fece invitare la figlia al seguito di Joannes Baptiste Spinellus, firmatario insieme al Barone Lo Tufo delle “Gratie e privilegi” concessi alla città di Monteleone da Ettore Pignatelli il 13 marzo 1504 cioè 4 anni prima della strage. Durante i festeggiamenti per le nozze di Margherita Lo Tufo, Diana, poco più che ventenne, uccise con il pugnale Giovanni (o Giacomo ) Lo Tufo nel palazzo baronale di Lavello in Lucania. Catturata venne processata e giustiziata.
San Gregorio d’Ippona (VV) La leggenda di Santa Ruba

A circa 2 km dal paese lungo la statale 182 verso Vibo Valentia sorge una chiesetta oggi chiamata Santa Ruba, che secondo una leggenda fu fatta costruire da Ruggero il Normanno per espiare un suo peccato confessato solo al fratello, papa Callisto II. Questa chiesa è costituita da una cupoletta centrale a forma di ombrello “lanciata con grazia sui tamburi cilindrici ornata di lesene e di merlatura” che ricorda l’architettura bizantina. La chiesa è circondata da una leggenda suggestiva. Si dice che essa doveva essere consacrata da Callisto II. Ma durante il suo viaggio verso Monteleone (oggi Vibo Valentia) Ruggero morì. Sua moglie Adelaide, per paura che il papa non avrebbe officiato la consacrazione e di perdere così la propria reputazione gli tenne nascosto, inventando delle scuse, la morte di Ruggero fino a cerimonia avvenuta. Callisto II sconvolto dal dolore la maledì dicendole che colui che gli aveva suggerito l’inganno le avrebbe roso il cervello. Adelaide, per paura, si fece costruire un sepolcro nella chiesa di Santa Ruba, con la pietra più pesante che esistesse. Ma il serpente penetrò lo stesso nel sepolcro rodendole il cervello. Così la leggenda vuole che il fantasma della contessa si aggiri per la chiesa e che durante le notti di tempesta si odano ancora le sue grida isteriche. Secondo un’altra leggenda, si crede che durante la dominazione francese a Monteleone (1806- 1815), i soldati nascosero un tesoro nella chiesa di Santa Ruba. Per ritrovarlo i cittadini di Monteleone e di Piscopio vi entrarono di notte e distrussero il pavimento poiché sognarono che il tesoro si trovasse dietro l’altare della Madonna, ma ad un certo punto furono colpiti da una pioggia di pietre e così fuggirono via. Si gridò al miracolo. Si crede anche che tale tesoro sia nascosto sotto la cupola e che solo tre fratelli riusciranno a recuperarlo ma soltanto uno di essi ne godrà visto che gli altri due moriranno.
Un’altra leggenda dice che la chiesa di Santa Ruba fu costruita da un ricco romano, in voto alla Madonna della Sanità per sfuggire alla pena del taglione. Si crede anche che la chiesa ed i suoi locali furono adibiti al Lazzaretto nel periodo delle epidemie e che Santa Ruba fosse una Santa orientale a cui i monaci Basiliani dedicarono la chiesa e il loro cenobio.
Si ringraziano: i volontari del Servizio Civile Universale di Brancaleone: Alessandra Sgrò, Antonino Guglielmini, Leonardo Condemi, tutti gli autori delle immagini, le fonti ed i vari siti per le informazioni utili fornite.
